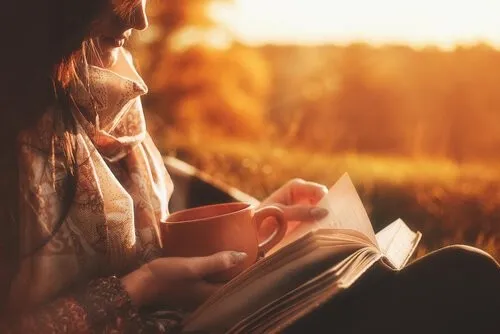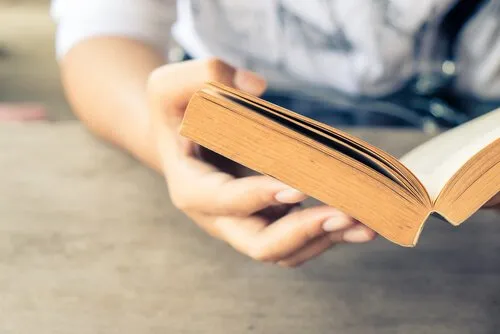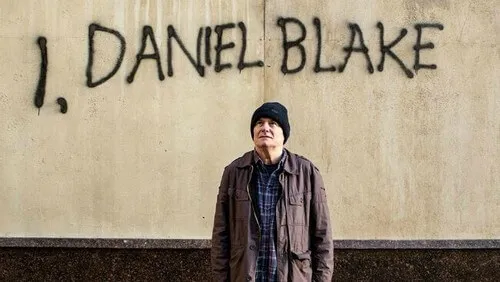Conosciamo tutti, in un modo o nell'altro, il concetto di ansia. Sappiamo che colpisce ogni persona in modo diverso e che esistono diversi disturbi ad esso correlati. Uno di questi è il disturbo d’ansia generalizzato . Nel DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali L’ansia è definita in diversi modi. Tra questi troviamo il disturbo d’ansia generalizzato o GAD.
Questo disturbo è caratterizzato dalla presenza di ansia e preoccupazioni eccessive e persistenti, difficili da controllare per il malato, riguardanti eventi o attività associati a tre o più sintomi di ipereccitazione fisiologica. Per la diagnosi di GAD l'ansia o la preoccupazione devono essere presenti quasi ogni giorno per un minimo di 6 mesi .
L’evoluzione del disturbo d’ansia generalizzato (GAD)
Il DAG è stato inizialmente introdotto come Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III APA 1980). Tuttavia, è stato utilizzato maggiormente come diagnosi residua per gli individui che non soddisfano i criteri diagnostici per altri disturbi d'ansia (1).
Nella pubblicazione del DSM-III-R il DAG è stato definito come una preoccupazione cronica e pervasiva (2). Successivamente nella pubblicazione del DSM-IV-TR il DAG venne indicato come ansia e preoccupazione eccessive che si verificano quasi tutti i giorni per almeno sei mesi in relazione a una varietà di eventi e attività .
La preoccupazione causa disagio e/o deterioramento funzionale ed è associata ad almeno tre dei seguenti:
- Irrequietezza, tensione o nervosismo.
- Difficoltà di concentrazione o vuoti di memoria.
- Irritabilità.
- Alterazioni del sonno.
- Presentano a mancanza di fiducia nella loro capacità di risolvere i problemi.
- Percepiscono i problemi come minacce.
- Si sentono frustrati di fronte a un problema.
- Sono pessimisti sull’esito degli sforzi per risolvere il problema.
- Il primo fattore stabilisce che le persone che soffrono di disturbo d'ansia generalizzato sperimentano il ipereccitazione emotiva o emozioni più intense di quelle vissute dalla maggior parte delle persone. Ciò riguarda sia gli stati emotivi positivi che quelli negativi, ma soprattutto quelli negativi.
- Il secondo fattore presuppone la scarsa comprensione delle emozioni da soggetti affetti da GAD. Ciò include un deficit nella descrizione e nell'etichettatura dei prodotti emozioni . Implica anche l’accesso e l’applicazione di informazioni utili che coinvolgono le emozioni.
- Rispetto a atteggiamenti più negativi sulle emozioni verso gli altri.
- Il quarto fattore regolazione emotiva adattiva minima o assente da individui che possiedono strategie di coping che potenzialmente si traducono in stati emotivi peggiori di quelli che inizialmente intendevano regolare.
- Esperienze interne
- Il rapporto problematico con i vissuti interni.
- Evitamento esperienziale
- Restrizione comportamentale
Terapia farmacologica e terapia cognitivo-comportamentale (TCC) sembrano essere efficaci per il trattamento del GAD (3 4 5). In questo disturbo, i farmaci possono essere efficaci nel ridurre i sintomi dell’ansia. Tuttavia, non sembrano avere un impatto significativo sulla preoccupazione che caratterizza il GAD (3).

Modelli teorici di riferimento per il disturbo d’ansia generalizzato
Modello di prevenzione delle preoccupazioni e DAG (MEP)
Il modello di evitamento delle preoccupazioni e il DAG (6) si basano sulla teoria bifattoriale della paura di Mowrer (1974). Questo modello a sua volta deriva dal modello di elaborazione emotiva di Foa e Kozak (7 8).
L'eurodeputato definisce la preoccupazione come un'attività linguistica verbale basata sul pensiero (9) che inibisce le immagini mentali vissute e l'eccitazione somatica ed emotiva associata. Questa inibizione dell'esperienza somatica ed emotiva evita l'elaborazione emotiva dell'esperienza Paura che è teoricamente necessario per un corretto adattamento ed estinzione (7).
Modello di intolleranza all'incertezza (MII).
Secondo il modello dell’intolleranza all’incertezza (MII). Gli individui affetti da GAD trovano situazioni di incertezza o ambiguità stressanti e fastidiose e sperimentano una preoccupazione cronica in risposta a tali situazioni. (10)
Questi individui credono che la preoccupazione serva loro o li aiuti ad affrontare in modo più efficace gli eventi temuti o a prevenire che tali eventi si verifichino (11 12). Questa preoccupazione, insieme ai sentimenti di ansia che la accompagnano, porta ad un approccio negativo al problema e ad un evitamento cognitivo che rafforza la preoccupazione.
Nello specifico, le persone che mantengono a approccio negativo al problema : (10)
Questi pensieri non fanno altro che esacerbare la preoccupazione e l'ansia (10).
Il modello metacognitivo (MMC)
Il modello metacognitivo di Wells (MMC) postula che gli individui con GAD sperimentano due tipi di preoccupazioni: tipo 1 e tipo 2. Preoccupazione di tipo 1 riguarda tutte le preoccupazioni relative ad eventi non cognitivi come situazioni esterne o sintomi fisici (Wells 2005).
Secondo Wells, le persone con GAD si preoccupano della preoccupazione di tipo 1. Temono che la preoccupazione sia incontrollabile e che possa essere intrinsecamente pericolosa. Questa preoccupazione della preoccupazione (cioè meta-preoccupazione) è chiamata da Wells Preoccupazione di tipo 2 .
La Preoccupazione di Tipo 2 è associata a una serie di strategie inefficaci volte a evitare la preoccupazione attraverso tentativi di controllare comportamenti, pensieri e/o emozioni. (10)

Modello di deregolamentazione delle emozioni
Il modello di deregolamentazione delle emozioni (MDE). Si basa sulla letteratura della teoria delle emozioni e sulla regolazione degli stati emotivi in generale . Questo modello è costituito da quattro fattori principali: (10)
Modello basato sull’accettazione del disturbo d’ansia generalizzato (MBA)
Secondo gli autori Roemer e Orsillo, l’MBA coinvolge quattro aspetti:
In questo senso lo suggeriscono gli ideatori del modello Gli individui con GAD rispondono con reazioni negative alle loro esperienze interne e sono motivati a cercare di evitare queste esperienze attuandola sia a livello comportamentale che cognitivo (attraverso la partecipazione ripetuta al processo di preoccupazione ).
Possiamo dire che i cinque modelli teorici condividono una parte molto importante: evitare le esperienze interne come strategia di coping. Negli ultimi anni la ricerca ha fatto notevoli progressi in termini di teorizzazione del disturbo. Appare chiara, tuttavia, la necessità di proseguire nella ricerca di base partendo dall’esame delle componenti predittive di questi cinque modelli.